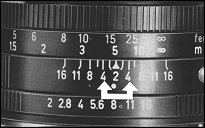|
Corso base di Tecnica Fotografica
OBIETTIVO
IPERFOCALE
|
Dalla scheda precedente emerge che la profondità di campo, ossia la zona che risulta a fuoco in modo accettabile sul fotogramma, si estende sia davanti che dietro il piano di messa a fuoco; l'entità di questa estensione cresce col diminuire della lunghezza focale, col diminuire del foro d'apertura del diaframma e con l'aumentare del circolo di confusione accettabile.
Ne deriva che l'operazione di mettere a fuoco sull'infinito e di chiudere molto il diaframma non ha, spesso, molto senso, perché sarebbe come voler estendere la profondità di campo oltre l'infinito. In altre parole, se si è alla ricerca della massima nitidezza in tutto il fotogramma, conviene mettere a fuoco su un piano intermedio tra la fotocamera e l'infinito.
In base a calcoli di ottica geometrica, dopo aver fissato il diametro del circolo di confusione accettabile, la lunghezza focale e il diaframma che si intendono impiegare, si ottiene la cosiddetta distanza iperfocale, ossia la distanza di messa a fuoco che garantisce l'estensione della nitidezza fino all'infinito; verso l'operatore la zona da considerare a fuoco è pari alla metà della distanza iperfocale.
Esistono quindi delle tabelle che forniscono i valori delle distanze iperfocali a seconda delle lunghezze focali e dei diaframmi impiegati. Ad esempio, con un obiettivo di focale 50 mm e con diaframma 8, si ha una iperfocale di circa 10 metri; significa che in quelle condizioni la profondità di campo si estende da 5 metri fino all'infinito. Ci possono essere discordanze tra le varie tabelle, a seconda del diametro del circolo di confusione considerato accettabile.
L'animazione seguente mostra, in successione, i risultati che si ottengono mettendo a fuoco sull'infinito, su una zona intermedia, sul primo piano o sull'iperfocale.
|

IPERFOCALE
L'animazione mostra i diversi effetti al variare del piano di messa a fuoco e del diaframma impiegato.
L'indicatore grigio a sinistra evidenzia la posizione del piano di messa a fuoco (nell'ordine di successione: infinito, intermedio, primissimo piano, iperfocale).
Il fotogramma con l'indicatore grigio più ampio corrisponde alla focheggiatura sulla distanza iperfocale.
(Idea tratta da "Il libro della Leica")
|
La perfetta conoscenza dei meccanismi che regolano la profondità di campo e l'iperfocale è indispensabile al fine di poter ottenere, in sede di scatto, l'effetto desiderato.
|
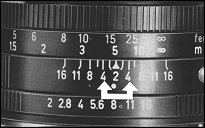


IPERFOCALE
Sugli obiettivi che possiedono la ghiera dei diaframmi in genere sono presenti i riferimenti che mostrano la zona a fuoco, a seconda del diaframma in uso e della distanza di focheggiatura.
I due esempi hanno in comune la distanza di messa a fuoco su 5 metri.
A sinistra le frecce indicano la profondità di campo che si ottiene col diaframma 4 (estesa all'incirca da 4,5 a 8 metri).
A destra si ha la profondità di campo con diaframma 16; come si vede, di ottiene tutto a fuoco da 2,5 metri all'infinito (è il caso dell'iperfocale).
(Obiettivo LEICA).
|
E' opportuno che ci si eserciti sul campo, effettuando diversi scatti per provare le varie combinazioni suggerite in queste schede; su un foglio si devono scrivere i dati di ogni scatto, per potere valutare sulle stampe o in proiezione i differenti risultati.
|
Argomenti collegati
Capitolo 2
|



|
Testo e immagini © Romano Cicognani - Riproduzione ammessa esclusivamente per uso strettamente personale - Ogni altro utilizzo su supporto cartaceo o elettronico dovrÓ essere autorizzato per iscritto dall'autore - Nomi di aziende, loghi e immagini di origine citata appartengono ai rispettivi proprietari.
|

|
Mappa dell'area

ABC


|